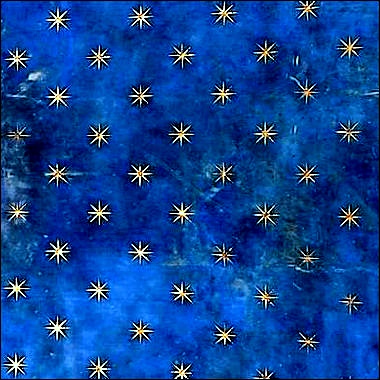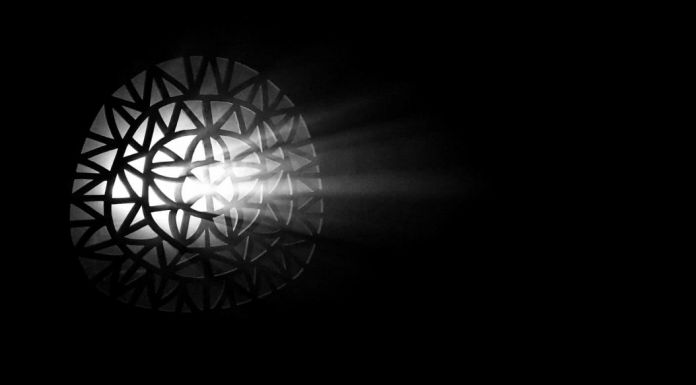Caro Giotto
eccomi a te dalle pagine di un romanzo appena finito, quello di Paolo Sorrentino ‘Hanno tutti ragione’, e di un altro appena iniziato, di Francesco De Sanctis ‘Romanzo da scrivere’: come trovarsi fuori strada, tra un mondo e pure quell’altro, lontano dai paesaggi quotidiani, con un passo dentro lo straniamento che ti dà la trasfigurazione della finzione, a gustare lo stordimento che spinge a superare la soglia e a sentire come attraverso un’altra pelle. Ecco allora che mentre il sole fa il suo giro più breve dell’anno, mi afferro all’ottava punta delle tue stelle nella Cappella degli Scrovegni a Padova: sono otto e annunciano un ottavo giorno che è forse quello che vorrei vedere nascere. Sono solo dettagli, quelle otto punte, eppure sono proprio quelle variazioni al margine che aprono lo sguardo e l’immaginazione, hanno il potere di spostare oltre la mappa già percorsa e mutare l’andatura. Come immergersi in quelle pagine o sollevare lo sguardo verso l’alto, verso Nord: nulla che possa scadere nel decorativo; la forma rivela il suo potere generativo nella funzione dichiarata di finzione – ed è figura o frammento – e si fa sapiente artificio che accompagna il paradisiaco uscire “a riveder le stelle”.
E così mi appare evidente un’affinità: tra quel tuo cielo stellato, Giotto, segnato da stelle a otto punte che brillano nell’alto della cappella e del suo sapiente divino blu, e l’opera in cartapesta a forma di rosone stellato di Salvatore Manzi, il suo Deuteroluogo, che un anno fa aveva trasformato la Saaci Gallery di Sabato Angiero a Saviano in spazio cosmico, luogo di transito dove incontrare il sacro della luce e della sua rarefatta sostanza e le sue ombre oblique. Dopo l’installazione di Salvatore Manzi in galleria a Saviano, m’ero tornata a chiedere il perché del temporaneo delle mostre: mi sarebbe piaciuto poter ripercorrere nel tempo quello stesso spazio per ritrovare la sacralità cosmica di quella luce a forma di stella dalle infinite punte. L’opera e lo spazio mi erano sembrati così un tutt’uno, destinato a permanere lì come stella lucente e a fare da dissonanza rispetto al resto delle architetture e di un paesaggio tutt’intorno troppo spesso maltrattati e abusati.
Eppure di lì a poco, e in nome della temporaneità, quello stesso spazio/galleria s’era mutato con la cura di Antonello Scotti in antro d’accesso alle profondità nascoste di una cava di sale per Nistagmo di Aniello Barone. Altro tracciato da percorrere e altra luce di cui quello spazio/galleria ha sedimentato memoria: percorso che si unisce agli altri tra cui rintraccio una traiettoria unica che credo abbia mosso Sabato Angiero da quel punto a Nord del Vesuvio a realizzare di volta in volta parte di un’idea progettuale più estesa, emersa poi in maniera più esplicita ed evidente a settembre scorso e per due settimane: quella che ha preso corpo a cielo aperto in SNÒDO, l’intervento espositivo lungo quattordici giorni nell’area mercatale di Saviano ad opera di quattordici artisti su quattordici cartelloni generalmente destinati alla pubblicità o alla propaganda elettorale. Un primo segno collettivo, pur se temporaneo nel suo accadere, che a me è parso necessario e mosso da un’urgenza di attenzione allo spazio pubblico, al paesaggio che attraversiamo distratti, talvolta troppo distratti, per accorgerci che l’abbandono che ci circonda nutre il paesaggio interiore, e coincide con una disattenzione dimentica della cura che richiederebbe lo spazio che abitiamo, il territorio cui diciamo di appartenere.
Torno con te ora, Giotto, da Padova a Saviano, allo SNÒDO, perché questo mi è sembrato un esempio, una piccola stella che orienta e dà concreta idea di come si possa ri-territorializzare l’abitare e restituire lo spazio/strada/piazzale al suo valore pubblico oltre che alla sua funzione di tracciato che connette, unisce e rende raggiungibili altre geografie. SNÒDO è la possibilità di restituire a quel piccolo punto terrestre – avrebbe detto Elsa Morante – la dignità di vivo tessuto urbano da sottrarre a una diffusa logica predatoria. Nessuna cappella edificata in questo caso, ma solo la prima edizione di un intervento in uno spazio pubblico grazie alla cura di Valentina Apicerni con i lavori degli artisti Cesare Accetta, Aniello Barone, Giuseppe Caccavale, Timothée Chalazonotis, Flaviana Frascogna, Salvatore Manzi, Olivier Menanteau, Pino Musi, Coutarel Odilon, Pier Paolo Patti, Felix Policastro, Antonello Scotti, Ciro Vitale e Nicola Zucaro. Eppure SNÒDO non può restare isolato né comparire solo come fugace evento un po’ fuori dall’ordinario. Troppo poco situare questa ‘operazione’ ai margini di un sistema geopolitico e culturale che ancora ragiona in termini di centro e periferia. Certo SNÒDO viene da lontano ed è un primo passo, direi quasi un primo movimento armonico, per spiazzare con un’altra possibile andatura ad opera di una piccola galleria d’arte che intende incidere nel contemporaneo. Come una delle stelle a otto punte del tuo cielo stellato, SNÒDO non è isolato né ‘marginale’ ma un fenomeno da leggere nell’insieme di un differente sguardo che consente di ricucire tra loro i differenti spazi metropolitani di Napoli e più precisamente della sua area Nord vesuviana e nolana, per riconoscerne i segni tangibili di un lento processo in atto che andrebbe governato proprio come azione d’insieme.
Si, Giotto, perché spostando il punto di vista, mi accorgo che la porta che fa da accesso a quest’area è quella dei quartieri di Piscinola e Scampia, a Nord di Napoli: terminale e snòdo ferroviario tra la linea metropolitana 1 e la linea ‘Arcobaleno’ che arriva fino ad Aversa, nel basso casertano: altra porta, quella, verso e dentro l’operosa Terra di Lavoro.
Dallo SNÒDO a cielo aperto a Saviano, mi collego allo snòdo ferroviario, denominato dalla Fondazione Plart che lo ha ideato e progettato, lo Scambiapassi, che è la stazione di Piscinola-Scampia dell’Ente Autonomo Volturno che da un anno è spazio riqualificato e restituito alla città, è strada e piazza coperta, luogo di transito per chi parte e arriva, architettura (firmata da Cherubino Gambardella e Simona Ottieri) che accoglie e dialoga con opere degli artisti Luciano Romano, Enzo Palumbo e Gianmaria Tosatti, e anche punto di incontro in una geografia urbana e metropolitana tutta da ridisegnare ancora e da connettere al resto che la circonda e pure a quel mare che pare lontano eppure arriva fin qui. Si, perché la bella intuizione di Luciano Romano ha generato la potente installazione visiva e sonora Song ‘e mare con cui si viene accolti nello spazio galleria/piazza della stazione: si tratta come dice l’artista di “Quattordici ritratti a figura intera, una messa in scena illuminata con intento teatrale e visionario, un conflitto tra il controluce del sole che rimbalza sulla superficie dell’acqua e la luce artificiale proiettata sui personaggi. La linea dell’orizzonte è uguale per tutti, come l’atteggiamento del corpo, un semplice passo in avanti, che cita l’iconico ritratto nella fotografia-manifesto La Rivoluzione siamo noi scattata nel 1971 a Villa Orlandi ad Anacapri, nel quale Joseph Beuys indaga il senso dell’arte in relazione alla sua fruizione sociale e sembra suggerire a chi lo guarda di scegliere da quale parte stare, se unirsi a lui o rimanere uno spettatore passivo”.
Una messa in scena di cui si diviene parte pure solo nel passaggio, o se si vuole nella sosta sulle panche, scegliendo da che parte guardare, ascoltando i suoni che arrivano dai quattordici ritratti a figura intera dei quattordici musicisti e cantanti che avanzano dal mare come seguendone il ritmo e il suo richiamo antico. Il movimento, la dimensione performativa, sono la condizione in cui vive quello spazio dove l’attraversamento diventa ogni volta differente occasione di interazione con altre presenze, altri materiali, altri allestimenti, fatti per guardare e immaginare un altrove. Mi è successo a Saviano con SNÒDO e a Scampia con Scambiapassi, nella passeggiata extramoenia che mi concedo pure in tempo di pandemia, dove l’opera e il singolo autore diventano parte costitutiva del luogo, non museo, non galleria, non mostra, ma tessuto vivo del corpo sociale che ne diventa esso stesso parte.
Posso così tornare a pensare il paesaggio come teatro, e il teatro come la condizione del vivere il paesaggio: quei luoghi sottratti all’incuria e al resto del degrado, che pure resta tutt’intorno, risplendono di luce nuova perché è lì che si torna a respirare senso civico, attenzione allo spazio come piazza/bene comune. Certo poi vuoi saperne di più di ogni singola opera, del progetto, dei diversi ‘attori’ coinvolti, e vai come me a questo o quel documento pubblicato, a questo o quel sito, e entri nei dettagli di ‘operazioni’ complesse e ambiziose per leggerne in filigrana gli sviluppi e intercettare un disegno e una volontà politica a governare un processo messo in moto ad opera di qualche coraggioso visionario o più spesso di molti raffinati artigiani del cambiamento. I nomi sono tanti e tutti importanti, Giotto, e per questo c’è un altro tempo da dedicare per ripercorrere e approfondire i dati necessari a dare forma alle importanti costellazioni istituzionali e territoriali cui ricondurre l’opere e l’operare complessivo e pure per riconoscere che l’Azienda Sanitaria Locale, tra dentro e fuori di quel luogo di transito, a Scampia, ha attivato lì il suo primo Open Point, il suo esperimento più prossimo di promozione della salute come benessere.
Segni importanti che annunciano l’inizio di un cambio di passo: senza stare ad aspettare, facendosi sensibili all’orizzonte offerto da questa o quell’opera, alzando o mutando lo sguardo, per sentirsi parte di quel tutto e pronti a unire geometrie con figure per riscattare la rovina e restituire dignità all’opera e al servizio pubblico, alla possibilità che la bellezza tragica dell’abbandono e della dimenticanza faccia spazio alla luce e al suo potere di attraversare il vuoto e le distanze siderali. È finalmente Natale anche lì quando la grotta accoglie la nascita e il passaggio a luce nuova: luce che io vedo arrivare da un’area estesa situata a Nord dello sterminator Vesevo e a Nord di quella parte dell’area metropolitana di Napoli che guarda il mare da lontano. A me, Giotto, è sembrato di vedere un unico grande spazio dove si è dato inizio a un’opera che sa di impresa collettiva, e fa del bene/benessere una questione di dominio pubblico. Forse non a caso il romanzo di Sorrentino termina con un sogno e quello di De Sanctis inizia con una domanda. Li metto insieme, Giotto, il sognare e il domandare, così m’appare tutto possibile ancora e tutto in un moto cosmico di quella materia stellare che cerca il modo di inverare l’ottava punta e di spingere ciascuno oltre le piste già segnate, a cogliere con Antonello Scotti il senso che per lui ha lo SNÒDO: che “è un ganglio di immaginazione, è uno studio del paesaggio interiore che ognuno di noi si porta, come atto di conoscenza con l’intento di tracciare un’altra orografia poetica. Non è un’antinomia tra periferia e centro, non è un modo per mostrare immagini-opere al di là degli spazi istituzionali, vuole essere un crocevia strutturale per dare voce a una parola non pubblicitaria, ma intellegibilmente pubblica, nel senso letterale di comunità intesa come totalità sociale”. Ecco allora che snòdo è già l’avvento, pratica scambiapassi da far splendere per l’avvenire urbano o vesuviano e pure metropolitano: da Padova a Scampia, passando per Saviano e molti oltre ancora.
COMMENTI
Sonia Lombardi: “Ecco la mia torcia della felicità: illumina il buio con la sua luce”!